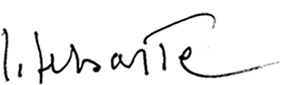Claudio Spadoni, dal catalogo “L’Alchimia della metamorfosi”, 2003
Tornano ancora utili le parole di un poeta, Mario Trufelli, per la pittura dell’amico Salvatore Sebaste, ad evocare “un brulicare di tensioni vitali, una fantastica risalita alle sorgenti recuperando un gesto e un segno primitivi…” Gesto e segno da intendere per quello che oggi possono essere, passate ormai diverse e lunghe stagioni da quegli anni ’40-‘50 nei quali tali termini espressivi furono come delle drammatiche stimmate nel corpo di una pittura che si voleva una cosa sola con l’esistenza, e insomma la sua più diretta e coinvolgente metafora. Dunque, se a distanza di mezzo secolo per un pitto-re come Sebaste si può legittimamente parlare di gesto e di segno, si dovrà anche precisare come queste indicazioni si calino in un ben diverso ordine di motivi, di stimoli, di consolidata consapevolezza. E s’intende che a questo riguardo sarà opportuno aggiungere anche un altro termine di riferimento, anch’esso carico di ulteriori implicazioni: materia, appunto, una materia che per il pittore lucano ha assunto un ruolo decisamente primario. D’altra parte, la sua storia personale ha preso a delinearsi in tempi già successivi alla tor-bida piena di un ‘informale’ alla lunga insostenibile. Piena poi ricondotta, infatti, entro la misura ben più tranquillizzante di una base linguistica non con-venzionale da cui ripartire per una nuova e più disincantata avanguardia. Quando non si trattasse proprio dell’indugio in “una moderna accademia dell’angoscia”, stando alla penna di Longhi, intinta come non di rado gli accadeva, nel veleno.
Sebaste era di una generazione più giovane di quegli ultimi espiatori di una condizione tragica di lontana ascendenza romantica, o forse meglio ancora di un ‘maledettismo’ tardoromantico. All’incirca coetaneo di quelli che furono i protagonisti di New Dada, Nouveau Réalisme, Pop, e per altri aspetti di Minimalismo e Arte cinetica e programmata, sulle prime s’era avviato su una strada più appartata, diciamo pure più simile ad un sentiero di periferia, della quasi sperduta periferia del Sud. Com’era inevitabile, si può ben comprendere, in quei tempi e in quei luoghi. L’aver reso fin quasi in chiave espressionista uno schietto omaggio a quanto poteva ancora resistere di una cultura di accenti paesani, e insomma ad una ancor credibile geografia della cultura, era la cartina di tornasole di un sincero sentimento di appartenenza ad una terra e alla sua vita dimessa. Fino a giungere “all’aneddoto locale, alle inflessioni perfino popolaresche”, che potevano indurre ad un patetismo dichiaratamente enfatizzato nel paradosso di un incontro, chissà quanto consapevole, fra gergo meridionalistico e icone quasi araldiche virate tuttavia in grottesco. Ma eccolo poi, Sebaste, smontare quasi d’improvviso quel-le narrazioni ‘rattratte’ e prosciugarne i timbri prima tanto accesi fin quasi a versare nel kitsch del manifesto a sfondo sociale, e quindi gradualmente ri-montare su livelli da verifica sperimentale. Certo, gli ‘azzeramenti’, come re-citava l’ultimo grido della parlata internazionale, non facevano per lui. Troppa materia e troppo grondante; materia contaminata e ‘bruta’, e troppi segni per una microgestualità non proprio asettica. La memoria di un Wols - evo-cata talora per il lavoro di Sebaste - se anche poteva aver contato qualcosa, non avrebbe più potuto indicare alcuna rotta credibile in una stagione culturale tanto mutata. Venivano poco a poco alla luce, semmai, certe implica-zioni simboliche della materia e del gesto prima d’allora inesplorate per da-zio pagato al racconto esemplarmente figurativo. Proprio quel ‘primitivo’ di cui parlava Trufelli prendeva ad emergere e ad informare di sé perfino i lacerti, le scorie, le tracce d’una realtà presente, di un quotidiano di impronta perfino tecnologica. Tanto che per meglio chiarire entro quali riferimenti lin-guistici potesse essere letto il lavoro maturo di Sebaste si potrebbero az-zardare, riprendendo indicazioni già offerte in passato, due riferimenti illustri, per quanto distanti, nel panorama artistico del ventesimo secolo: Kan-dinskij e Dubuffet. Il primo, per tutti i richiami alla valenza simbolica, appun-to, dei segni e a quelle “risonanze interiori” che certo intrigano il lavoro del pittore di Bernalda. L’altro, per tutto ciò che riguarda una materiologia capa-ce di assumere inflessioni diverse, insieme di ‘brutalismo’ e di ricercatezza, di ‘naiveté’ e di lavorìo linguistico. Per altri aspetti, i poli di riferimento potrebbero intendersi anche nel senso della grande astrazione e del grande realismo di cui aveva parlato proprio il pittore russo, e al tempo stesso di una moderna auscultazione della materia quasi per coglierne gli echi più lontananti, le suggestioni dell’ancestrale. Proprio in quest’ottica credo si possano vedere le serie solo in apparenza contrapposte dei ‘bianchi’ e dei ‘neri’, gravidi gli uni come gli altri di materia: la stessa materia, ma offerta quasi in versione diurna e notturna. Del resto, bianco e nero sono ‘non colo-ri’, o se si vuole l’alfa e l’omega del colore. La storia dei ‘monocromi’ del secolo scorso, in realtà ancora tutta da risistemare e possibilmente con occhi sgombri da pregiudizi o tabelle di valori predefinite, potrebbe spiegare me-glio il senso, anzi i diversi sensi di quegli approdi estremi. E tuttavia, anche a voler tenere per indicativi certi esempi in merito, per Sebaste e la sua vi-cenda ‘materiologica’, si dovrà almeno aggiungere che nulla viene perduto, in questi suoi ‘bianchi’ e ‘neri’, anche della complessità di un racconto già precedentemente offerto in una gamma cromatica tra le più squillanti, acce-se. Racconto che, anzi, si fa forse più profondo e suadente. E sempre, co-munque, in una trama di stratificazioni di materie che altro non sono che ‘memoria’ e contaminazione di realtà, come affondate nel non colore a sug-gerire forse i fantasmi o le ombre di più remote lontananze.