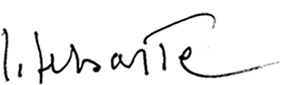Donato Valli, “Microstoria di Salvatore Sebaste”, dal catalogo “Dilatazione delle potenzialità”, 1995.
Il libro come prezioso oggetto di arte aperta, votata alla complementarità di colore e scrittura, è una costante dell’attività creativa di Sebaste, almeno da quando, compiuto l’inevitabile di-scepolato d’ogni esordio, il giovane artista, emigrato dal natio Salento nella Basilicata, sua seconda patria, comincia a muoversi autonomamente lungo i sentieri di un diuturno, appas-sionato, esaltante esercizio. L’incontro con i poeti di questa patria di adozione, in particolare Sinisgalli, Trufelli, Nigro, è anche occasione di verifica e di approfondimento delle ragioni di un’arte vorace, che pur nella fissità di un archetipo culturale ben storicizzabile, ha bisogno sempre di nuovi stimoli e di nuove esperienze. Archeologia controluce, uno dei primi risultati concreti del lungo sodalizio con Trufelli, presenta già quattro acqueforti in cui la suggestione del chiaro-scuro diventa simbolica della commissione delle due patrie e, ancora più a fondo, della dialettica tra conoscenza e mistero. L’originaria cultura mistica e orfica propria della re-gione appulo-lucana si sposta e si comprime verso un sacrale mondo onirico, capace di ri-scattare l’inerzia della materia e l’eco di antichi silenzi.
Siamo al 1972. La mostra di Bologna dell’anno successivo conferma che Sebaste non è un pittore illustrativo, ma allusivo. In fondo anche la sua complementarità con i testi non è di tipo iconografico, ma esegetico-gnomico, perché ne scopre i significati non descrittivi, non pacifici. L'arte insiste sulla trasfigurazione, sulla funzione metaforica, poetica del colore; la massa ap-parentemente omogenea della densità tonale lascia intravedere una magmatica vita di segni e di linee chiaroscurali che genera l’ansia di una possibilità di accadimenti, dell’imminenza della storia. Gli stupori dell’origine salentino-barocca uniti alla dolente lucana memoria ine-splosa presiedono alla nascita di un mondo di oggetti popolari e contadini, esasperati nella prepotenza della luce-colore, di un contrasto non più chiaroscurale ma oppositivo fino al pa-rossismo di una pietà che s’impone di essere crudele per troppo amore e partecipazione.
Qualche anno ancora e in Coincidenze (1976) si chiarisce il senso e il significato di questi “macrosegni” della pittura di Sebaste. Essi assumono un valore simbolico in quanto presup-pongono un racconto di vicende non esplicitamente narrate. Grava l’oggettività dell’inerzia materiale del segno e del colore; ma l’uno e l’altro si collegano, si correlano con sentimenti, frustrazioni, ambiguità, illusioni di plebi sconfitte e, soprattutto, con gli struggimenti interiori di un mondo che si rastrema sempre più verso un esito di soggettiva religiosità e di incontenibile esistenza. E, per quanto possa sembrare contraddittorio, proprio la massiccia, inamovibile certezza del segno, la sua terragna e terrestre valenza, si caricano di simboli appena percet-tibili consentendo a quei sentimenti di perdurare in una dimensione di confessione più che di racconto, di scaricarsi, cioè, in una implosione salvifica e liberatrice. Qui confluiscono le radici storico-esistenziali del pittore, le sue esperienze tecniche e vitali, la sua volontà di concepire la pittura come segno di un racconto possibile, che solo la confessione può liberare.
Ma la conquista non è definitiva. Le “composizioni” pittoriche di Dissociazione (1980) sono la chiara contrapposizione ai “pieni” chiaroscurali delle coincidenze (1976). Il pittore tende a so-stituire la compattezza del disegno, marcato sulla tela con fasce intenzionalmente larghe e spesse, esattamente col suo opposto. Si ha una sorta di coincidentia oppositorum in cui ri-mane salvo il presupposto discorsivo, che però è demandato all’osservatore-fruitore con lo scopo di coinvolgerlo direttamente nella ricerca di senso e di interpellarlo sul mondo dell’invisibile e dell’inesprimibile. Il procedimento è di tipo deduttivo, in quanto è frutto di con-venzione logica più che di osservazione della realtà. “Dissociazione” è, infatti, concetto riferibile tanto ai contenuti quanto alla tecnica, che mira a scomporre il colore fino al minimo comune denominatore, che è il bianco, matrice primaria di ogni luce e di ogni potenzialità figurale. Occorreva, di conseguenza, dare spessore al bianco, vale a dire al sospiro, all’idea di colore, compattarlo attraverso un’operazione che desse rilievo alla sua mancanza, alla sua assenza: quasi si trattasse di spuma d’essere, analoga alla nebulosa che, per differenza di densità materica, ha dato origine alla vita e all’individuo signata quantitate. E’ un’operazione concettuale prima che figurativa fino al punto da costringere lo stesso colore a costituirsi come correlato del processo astrattivo del pensiero. Esso diventa il corrispettivo della pagina bianca mallarmeana con in più una sfumata evocazione di cosmiche epopee, di apocalittiche epifanie che accentuano ancora una volta la genesi simbolica, meta letteraria della pittura di Sebaste.
Come su questo paesaggio di assenza e di attesa, su questa sconfinata potenzialità dell’accadimento abbia potuto inserirsi la nascita del colore, quasi Venere sorgente dalle ac-que; e come tutto questo fosse in linea archetipica con il gusto fisico dell’impasto delle carta-peste macerate nella mitica povertà dell’artigiano salentino e in particolare leccese, è storia (o leggenda) che Sinisgalli ha narrato con gusto di poeta e intuito di matematico nella prefazione ad Archetipo in piega rossa: “Il Mostro ottuso è stato umiliato dall’intelligenza di Apollo. Ora, dopo gli sporadici approcci al dialetto, varcato il calvario dell’inespresso, rotta la cecità della materia degradata, lo scoppio dell’allegrezza, del colore, segna il principio di una vita nuova. Sebaste può ora conciliare istinti e calcolo, mediare gentilezza e forza. I tufi pugliesi e le crete basilische sono lievitate dalla luce dell’aurora. La salute è tornata a fiorire". Siamo all’anno 1980, che precede quello dell’improvvisa morte del poeta.
Questa compiuta scoperta del colore inebria l’artista, gli conferisce entusiasmo, lo costringe a ripensare il passato, la vita, a riscriverla, o meglio a ridipingerla nella varietà delle sue sfac-cettature. Infatti, essa giaceva dentro la sua memoria, era divenuta sedimento della carne, consustanziale alla cultura di un Sud orfíco e pitagorico, superstizioso e credente, solare e tenebroso, nel quale la prepotenza della vita s’intreccia con l’angoscia di immani lutti: blocchi di pietra e levità d’ali trasvolanti su spazi celesti, su nudità di metafisiche leggende, brandelli d’anima sospesi a ricordi ancestrali. Tutto si riversa sulla tela in una sorta di espressionismo ambiguo, che unisce grazia e profondità, leggerezza di spazi e pesante materia di colori, inat-tesi fondali di neutro pallore con rocciose tenebrosità terrestri. La rivisitazione ha il senso gioioso dell’epifania, coagula tronchi di corpi e lacerti di realtà in una sorta di apocalisse fe-stosa dove si leggono suggestioni essenzializzate di altre presenze, di altre culture legate al fascino della terra lucana: Levi, Ortega, Guttuso... (vedi Frammenti della memoria, Necessa-ria poiesi, 1982; Il tuffo sulla collina, 1985).
Quando Sebaste emerge, alla fine degli anni Ottanta, da questo bagno nell’acceso sogno della sua interiorità, da questa sorta di espressionismo improprio, non scolastico, si può dire che egli ha già percorso per intero il periplo della sua insularità artistica, ritornando, in un cer-to senso, al punto di partenza. Solo che adesso egli vi ritorna con il bagaglio delle esperienze compiute e, soprattutto, con la riacquistata certezza che l’esito della conoscenza più pura non è nella metafora del reale, nel compiacimento del discorso interrotto, nella sostituzione dei re-ferenti oggettivi, appena tenuti insieme dalla precarietà di un colore onnisemantico, bensì nel-la consistenza del colore su se stesso, nella responsabilità che esso si assume in quanto e-spresso, gestito, di significare il reale nella sua totalità. Siamo, cioè, ai limiti dell’informale. Dico ai limiti perché anche qui si tratta di un informale reinventato, la cui schematicità definito-ria vale soltanto a connotare un’attitudine tesa ad esaltare l’identità di segno e significato. Nell’apparente frammentarietà delle risultanze figurative, che vanno dalla giustapposizione dei colori alla loro íntersecazione e caotica fusione attraverso tracciati iperbolici di linee, dalla constatazione d’un conflitto inerziale, autodefinito, al recupero di una vena di gioioso dilettan-tismo non alieno da infanzie memoriali e da nativi trasalimenti, nasce una nuova religione dell’unità non più come dato esterno e programmatico, ma come desiderio di sogno, di fanta-sia, contrapposto a un mondo sempre più piatto, incolore. Il movimento, il rifiuto della forma definita, l’esaltazione del colore come identità del mondo sono la risposta dell’artista alla mi-naccia dell’esistenziale sconfitta di ogni uomo.
Ma possiamo essere certi che non siamo all’ultima tappa del cammino di Sebaste. Egli è un artista “itinerante”, non conosce la sedentarietà. D’altra parte, è arrivato a un vertice in cui, dopo aver attraversato l’esperienza dell’avanguardia e la poetica del colore, ha attinto il suo punto di fusione, di reversibilità, e quindi di dilatazione delle potenzialità espressive. Una volta svincolato il segno non solo dalla mimesi realistica, non solo dalla metafora figurativa delle avanguardie storiche, non solo dalla stessa frantumazione onirica dell’astratto e dell’informale, ma dalla stessa razionalità sottesa alla coerenza conativa della pittura, Seba-ste ha davanti a sé una plaga indefinita di soluzioni, non esclusa quella di una riconquista del figurativo, che di tanto in tanto lo attira con un sentimento di inappagata nostalgia. Ma allora, quando ciò avviene, come a volte è avvenuto, è fatale che un'increspatura di superiore ironia continui a ricondurci al presentimento di altri cieli e di altre vite.